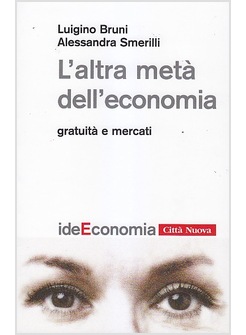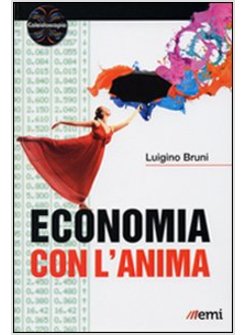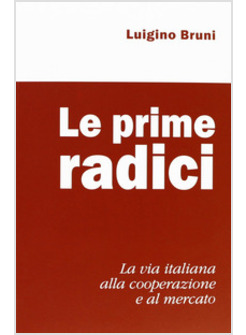Autori Principali
Libri di BRUNI LUIGINO
-
FIDARSI DI UNO SCONOSCIUTO. ECONOMIA E VIRTU' NEL TEMPO DELLE CRISI
BRUNI LUIGINO
Editore: EDIZIONI DEHONIANE BOLOGNA
Data di pubblicazione: Febbraio 2015
Perché dovrei fidarmi di uno sconosciuto? A questa domanda fondamentale di ogni economia di mercato si potrebbe rispondere che la storia degli scambi e dei commerci ha lungamente beneficiato della fiducia e della giustizia e che nel tempo delle crisi anche tutte le altre virtù - dalla speranza alla prudenza, dalla fortezza alla temperanza - hanno svolto e svolgono un ruolo importante. La spersonalizzazione delle relazioni economiche dipende in larga parte da un sistema finanziario lontanissimo e indipendente dai rapporti umani di fiducia, retto sulla ricerca del massimo tornaconto dei proprietari delle grandi banche, delle assicurazioni e delle imprese multinazionali. Per superare questo modello di sviluppo, de-mercantizzare la società, sottrarsi alla logica esclusiva delle merci, dei prezzi e del consumo, ridare valore alle cose oltre il calcolo utilitaristico servirebbero un coraggio civile e una forza di pensiero pari almeno a quelli che generarono il movimento cooperativo europeo. All'alba del capitalismo esso aveva tentato un'altra via al mercato e all'impresa, e per questo metteva in discussione i diritti di proprietà, la distribuzione del reddito (un tema ormai uscito dai libri di economia), il potere, l'uguaglianza delle opportunità tra i soggetti economici, senza negare né la libertà né il mercato.DISPONIBILE IN 7/8 GIORNI
€ 8,50Perché dovrei fidarmi di uno sconosciuto? A questa domanda fondamentale di ogni economia di mercato si potrebbe rispondere che la storia degli scambi e dei commerci ha lungamente beneficiato della fiducia e della giustizia e che nel tempo delle crisi anche tutte le altre virtù - dalla speranza ... alla prudenza, dalla fortezza alla temperanza - hanno svolto e svolgono un ruolo importante. La spersonalizzazione delle relazioni economiche dipende in larga parte da un sistema finanziario lontanissimo e indipendente dai rapporti umani di fiducia, retto sulla ricerca del massimo tornaconto dei proprietari delle grandi banche, delle assicurazioni e delle imprese multinazionali. Per superare questo modello di sviluppo, de-mercantizzare la società, sottrarsi alla logica esclusiva delle merci, dei prezzi e del consumo, ridare valore alle cose oltre il calcolo utilitaristico servirebbero un coraggio civile e una forza di pensiero pari almeno a quelli che generarono il movimento cooperativo europeo. All'alba del capitalismo esso aveva tentato un'altra via al mercato e all'impresa, e per questo metteva in discussione i diritti di proprietà, la distribuzione del reddito (un tema ormai uscito dai libri di economia), il potere, l'uguaglianza delle opportunità tra i soggetti economici, senza negare né la libertà né il mercato.
-
MICROECONOMIA UN TESTO DI ECONOMIA CIVILE
BECCHETTI LEONARDO, BRUNI LUIGINO, ZAMAGNI STEFANO
Editore: IL MULINO
Data di pubblicazione: Ottobre 2014
La microeconomia si è aperta negli ultimi tempi a nuovi stimoli, integrando fra loro argomenti della ricerca psicologica e sociologica da un lato e dell'economia sperimentale e comportamentale, dall'altro. Il microcredito, l'economia verde, il commercio equo e solidale, il variegato mondo dell'associazionismo, l'imprenditorialità sociale, non più realtà di nicchia, contribuiscono in modo rilevante a creare valore sociale e ambientale, oltre che economico, per migliorare le prospettive di felicità pubblica. Questa nuova edizione aggiornata si arricchisce di un paragrafo dedicato alla problematica dei beni comuni.DISPONIBILE SUBITO
€ 36,00La microeconomia si è aperta negli ultimi tempi a nuovi stimoli, integrando fra loro argomenti della ricerca psicologica e sociologica da un lato e dell'economia sperimentale e comportamentale, dall'altro. Il microcredito, l'economia verde, il commercio equo e solidale, il variegato mondo dell'associazionismo, ... l'imprenditorialità sociale, non più realtà di nicchia, contribuiscono in modo rilevante a creare valore sociale e ambientale, oltre che economico, per migliorare le prospettive di felicità pubblica. Questa nuova edizione aggiornata si arricchisce di un paragrafo dedicato alla problematica dei beni comuni.
-
L'ALTRA META' DELL'ECONOMIA. GRATUITA' E MERCATI
BRUNI LUIGINO, SMERILLI ALESSANDRA
Editore: CITTA' NUOVA
Data di pubblicazione: Maggio 2014
L'Altra metà dell'economia. L'economia invisibile agli occhi dell'economia, che ha per protagonista la gratuità. La gratuità intesa come Charis, come dono è una dimensione costitutiva della vita e dell'essere umano, anche dell'homo oeconomicus. Quando l'economia nasce nel 700/800, le virtù della gratuità, della libertà e del rispetto della persona erano una dimensione che faceva parte della cultura del tempo, presente e abbondante. Oggi riportare la gratuità dentro l'economia significa ribaltare le logiche del profitto e della finanza per rimettere al centro dell'economia la persona e le sue motivazioni, la sua dignità, gli ideali, i sentimenti, i poveri. Il libro sottolinea il contributo fondamentale e insostituibile svolto dalle comunità carismatiche religiose e dal genio femminile nello sviluppo economico, sociale, culturale della nostra civiltà. Ed evidenzia il fondamentale apporto offerto da imprenditori, politici, giornalisti, oggi capaci di quella Charis che dà loro la capacità di uno sguardo diverso sul mondo e nella società contemporanea.DISPONIBILE IN 4/5 GIORNI
€ 16,00L'Altra metà dell'economia. L'economia invisibile agli occhi dell'economia, che ha per protagonista la gratuità. La gratuità intesa come Charis, come dono è una dimensione costitutiva della vita e dell'essere umano, anche dell'homo oeconomicus. Quando l'economia nasce nel 700/800, le virtù della ... gratuità, della libertà e del rispetto della persona erano una dimensione che faceva parte della cultura del tempo, presente e abbondante. Oggi riportare la gratuità dentro l'economia significa ribaltare le logiche del profitto e della finanza per rimettere al centro dell'economia la persona e le sue motivazioni, la sua dignità, gli ideali, i sentimenti, i poveri. Il libro sottolinea il contributo fondamentale e insostituibile svolto dalle comunità carismatiche religiose e dal genio femminile nello sviluppo economico, sociale, culturale della nostra civiltà. Ed evidenzia il fondamentale apporto offerto da imprenditori, politici, giornalisti, oggi capaci di quella Charis che dà loro la capacità di uno sguardo diverso sul mondo e nella società contemporanea.
-
FONDATI SUL LAVORO
BRUNI LUIGINO
Editore: VITA E PENSIERO
Data di pubblicazione: Maggio 2014
Di lavoro oggi si discute molto, principalmente riguardo alla sua profondissima crisi e alle scelte politiche che dovranno sanarne le drammatiche emergenze. Ma il lavoro non ha soltanto a che fare con la produzione di ricchezza e benessere materiale: esso 'fonda' la Repubblica italiana, come recita l'articolo 1 della nostra Costituzione, e soprattutto fonda tutti noi, che siamo veramente cittadini perché lavoriamo, lavoreremo, abbiamo lavorato (o perché non possiamo lavorare pur volendolo fare). Spesso, in questo parlar molto del lavoro, ci si sofferma troppo, se non esclusivamente, sui suoi aggettivi - precario, dipendente, autonomo, nero... - mentre viene elusa la domanda decisiva: che cosa è il lavoro? Su questo riflette qui Luigino Bruni, esplorando i temi del lavoro non sotto forma di un trattato sistematico, bensì con felici escursioni tra la vita e la teoria, senza mai perdere di vista la valenza fondativa del lavoro nella vita umana. Ecco allora la ripresa in questa prospettiva della lunga storia del lavorare degli uomini e delle donne, fino al rapido tramonto delle forme del lavoro contadino e poi di quello della fabbrica, dove si erano condensati secoli, se non millenni, di storia di arti e mestieri, di professioni e abilità. Un tramonto dopo il quale non si intravede ancora con chiarezza quale sarà il futuro delle nuove forme di produzione di beni e servizi: se una modalità più umana e umanizzante o invece il ritorno di una dipendenza quasi servile, una sorta di neo-feudalesimo. E poi, l'attenzione alle realtà giovanili, schiacciate tra la fine dei mestieri e la chiusura dei mercati, eppure miniere di speranza che la scuola e la formazione possono ancora far fiorire. E infine, la rilettura sotto una nuova luce delle 'parole' del lavoro: a cominciare da charis, 'gratuità', passando per oikonomia, la vera 'economia', cioè il bene comune domestico, per arrivare a 'festa', la dimensione autentica del lavoro come lo intende Bruni, vale a dire la produzione all'interno della dimensione relazionale e simbolica, della fraternità e del dono reciproco.DISPONIBILE IN 6/7 GIORNI
€ 15,00Di lavoro oggi si discute molto, principalmente riguardo alla sua profondissima crisi e alle scelte politiche che dovranno sanarne le drammatiche emergenze. Ma il lavoro non ha soltanto a che fare con la produzione di ricchezza e benessere materiale: esso 'fonda' la Repubblica italiana, come ... recita l'articolo 1 della nostra Costituzione, e soprattutto fonda tutti noi, che siamo veramente cittadini perché lavoriamo, lavoreremo, abbiamo lavorato (o perché non possiamo lavorare pur volendolo fare). Spesso, in questo parlar molto del lavoro, ci si sofferma troppo, se non esclusivamente, sui suoi aggettivi - precario, dipendente, autonomo, nero... - mentre viene elusa la domanda decisiva: che cosa è il lavoro? Su questo riflette qui Luigino Bruni, esplorando i temi del lavoro non sotto forma di un trattato sistematico, bensì con felici escursioni tra la vita e la teoria, senza mai perdere di vista la valenza fondativa del lavoro nella vita umana. Ecco allora la ripresa in questa prospettiva della lunga storia del lavorare degli uomini e delle donne, fino al rapido tramonto delle forme del lavoro contadino e poi di quello della fabbrica, dove si erano condensati secoli, se non millenni, di storia di arti e mestieri, di professioni e abilità. Un tramonto dopo il quale non si intravede ancora con chiarezza quale sarà il futuro delle nuove forme di produzione di beni e servizi: se una modalità più umana e umanizzante o invece il ritorno di una dipendenza quasi servile, una sorta di neo-feudalesimo. E poi, l'attenzione alle realtà giovanili, schiacciate tra la fine dei mestieri e la chiusura dei mercati, eppure miniere di speranza che la scuola e la formazione possono ancora far fiorire. E infine, la rilettura sotto una nuova luce delle 'parole' del lavoro: a cominciare da charis, 'gratuità', passando per oikonomia, la vera 'economia', cioè il bene comune domestico, per arrivare a 'festa', la dimensione autentica del lavoro come lo intende Bruni, vale a dire la produzione all'interno della dimensione relazionale e simbolica, della fraternità e del dono reciproco.
-
RICCHEZZE BEATI QUELLI CHE INVESTIRANNO IN ECONOMIE DI COMUNIONE
BRUNI LUIGINO
Editore: SAN PAOLO
Data di pubblicazione: Aprile 2014
Esiste una ricchezza altra dal denaro, dalla proprietà, dalla merce di scambio. Una ricchezza di enorme potenziale composta di virtù e relazioni che nascono e si muovono all'interno di comunità coese, società caratterizzate da un alto livello di comunione. Beni che non si sottraggono o comprano, ma si moltiplicano e intrecciano. Relazioni e rapporti alla base della buona vita di ogni cittadino, e perfino alla base di un fecondo mercato. Ma cosa significa, in questa prospettiva, essere ricchi?DISPONIBILE IN 11/12 GIORNI
€ 4,50Esiste una ricchezza altra dal denaro, dalla proprietà, dalla merce di scambio. Una ricchezza di enorme potenziale composta di virtù e relazioni che nascono e si muovono all'interno di comunità coese, società caratterizzate da un alto livello di comunione. Beni che non si sottraggono o comprano, ... ma si moltiplicano e intrecciano. Relazioni e rapporti alla base della buona vita di ogni cittadino, e perfino alla base di un fecondo mercato. Ma cosa significa, in questa prospettiva, essere ricchi?
-
ECONOMIA CON L'ANIMA
BRUNI LUIGINO
Editore: EMI
Data di pubblicazione: Maggio 2013
Davanti a un'economia impazzita, onnipresente e disumanizzante, l'autore fa una lettura in profondità dei processi in atto. Ci mostra le conseguenze anche antropologiche delle trasformazioni in corso e puntualizza una proposta per un'economia veramente umana (nella politica, nella finanza, nella società). Lo fa grazie a un linguaggio accessibile a tutti, e con esempiconcreti e comprensibili anche al lettore non specialista.DISPONIBILE : NON AL MOMENTO
€ 12,00Davanti a un'economia impazzita, onnipresente e disumanizzante, l'autore fa una lettura in profondità dei processi in atto. Ci mostra le conseguenze anche antropologiche delle trasformazioni in corso e puntualizza una proposta per un'economia veramente umana (nella politica, nella finanza, nella ... società). Lo fa grazie a un linguaggio accessibile a tutti, e con esempiconcreti e comprensibili anche al lettore non specialista.
-
LE PRIME RADICI. LA VIA ITALIANA ALLA COOPERAZIONE E AL MERCATO
BRUNI LUIGINO
Editore: IL MARGINE
Data di pubblicazione: Gennaio 2013
I MERCATI IN CRISI NERA,DISPONIBILE : NON AL MOMENTO
€ 16,00
IL PIL IN PICCHIATA
MA LA COOPERAZIONE CI SALVERÀ
Le radici storiche dell'impresa cooperativa, la sua specialissima via al mercato, la sua forza, il suo futuro. Un libro per capire che la crisi economica non si supera con i vecchi schemi ma scommettendo su un modello diverso, tutto italiano. Che già oggi funziona, anche se i giornali non lo raccontano.
L'ECONOMIA CIVILE:
LE PERSONE PRIMA DEI SOLDI
Le prime radici è un saggio intrigante e illuminante, perché obbliga il lettore a liberarsi dei luoghi comuni sulla cooperazione italiana, un movimento che è tra i più robusti e avanzati del mondo occidentale. Fondando l'agire economico sui princìpi di reciprocità-mutualità e di fraternità, è il più efficace veicolo per affermare l'economia civile di mercato (dalla prefazione di Stefano Zamagni).I MERCATI IN CRISI NERA,
IL PIL IN PICCHIATA
MA LA COOPERAZIONE CI SALVERÀ
Le radici storiche dell'impresa cooperativa, la sua specialissima via al mercato, la sua forza, il suo futuro. Un libro per capire che la crisi economica non si supera con i vecchi schemi ma scommettendo ... su un modello diverso, tutto italiano. Che già oggi funziona, anche se i giornali non lo raccontano.
L'ECONOMIA CIVILE:
LE PERSONE PRIMA DEI SOLDI
Le prime radici è un saggio intrigante e illuminante, perché obbliga il lettore a liberarsi dei luoghi comuni sulla cooperazione italiana, un movimento che è tra i più robusti e avanzati del mondo occidentale. Fondando l'agire economico sui princìpi di reciprocità-mutualità e di fraternità, è il più efficace veicolo per affermare l'economia civile di mercato (dalla prefazione di Stefano Zamagni). -
LE NUOVE VIRTU' DEL MERCATO NELL'ERA DEI BENI COMUNI
BRUNI LUIGINO
Editore: CITTA' NUOVA
Data di pubblicazione: Marzo 2012
L'attuale crisi economica e finanziaria ha generato un dibattito profondo sul tema. Cos'è il mercato? Chi è l'imprenditore? Ciò che lo muove è la ricerca esclusiva del profitto? L'Autore offre un contributo alla riflessione in corso.DISPONIBILE IN 4/5 GIORNI
€ 20,00L'attuale crisi economica e finanziaria ha generato un dibattito profondo sul tema. Cos'è il mercato? Chi è l'imprenditore? Ciò che lo muove è la ricerca esclusiva del profitto? L'Autore offre un contributo alla riflessione in corso.
-
LEGGEREZZA DEL FERRO UN'INTRODUZIONE ALLA TEORIA ECONOMICA DELLE ORGANIZZAZIONIE
BRUNI LUIGINO, SMERILLI ALESSANDRA
Editore: VITA E PENSIERO
Data di pubblicazione: Gennaio 2011
L'economia, e con essa la società, sta attraversando una fase di cambiamento epocale. Le imprese e i mercati attuali si allontanano sempre più dal modello con il quale li abbiamo immaginati, vissuti e descritti solo fino a pochi decenni fa. In particolare, ai fini del successo delle imprese, diminuisce il peso relativo dei capitali tecnologici e finanziari e aumenta quello delle persone, del capitale sociale, civile e motivazionale e quello dei beni relazionali. In un tale contesto, la risorsa più scarsa, e quindi più fragile, diventa l'arte di tessere relazioni, la capacità di far sì che la diversità umana, dentro e fuori le imprese, non imploda nel caos e nell'anarchia, ma dia luogo a nuove sinergie. Anche per queste ragioni il libro parla soprattutto di rapporti, di persone, di motivazioni all'interno dell'economia e in particolare delle organizzazioni, e lo fa a partire da quelle nelle quali è evidente il ruolo cruciale svolto dalle persone e dalle loro motivazioni: le cosiddette Organizzazioni a Movente Ideale (OMI). Queste verranno analizzate soprattutto nei momenti di crisi relazionale e motivazionale, quando si rischia con più probabilità di perdere le persone migliori.DISPONIBILE SUBITO
€ 14,00L'economia, e con essa la società, sta attraversando una fase di cambiamento epocale. Le imprese e i mercati attuali si allontanano sempre più dal modello con il quale li abbiamo immaginati, vissuti e descritti solo fino a pochi decenni fa. In particolare, ai fini del successo delle imprese, ... diminuisce il peso relativo dei capitali tecnologici e finanziari e aumenta quello delle persone, del capitale sociale, civile e motivazionale e quello dei beni relazionali. In un tale contesto, la risorsa più scarsa, e quindi più fragile, diventa l'arte di tessere relazioni, la capacità di far sì che la diversità umana, dentro e fuori le imprese, non imploda nel caos e nell'anarchia, ma dia luogo a nuove sinergie. Anche per queste ragioni il libro parla soprattutto di rapporti, di persone, di motivazioni all'interno dell'economia e in particolare delle organizzazioni, e lo fa a partire da quelle nelle quali è evidente il ruolo cruciale svolto dalle persone e dalle loro motivazioni: le cosiddette Organizzazioni a Movente Ideale (OMI). Queste verranno analizzate soprattutto nei momenti di crisi relazionale e motivazionale, quando si rischia con più probabilità di perdere le persone migliori.
-
ITALIA VITA E AVVENTURE DI UN'IDEA
BRUNI LUIGINO
Editore: IL MULINO
Data di pubblicazione: Novembre 2010
Se l'Italia come stato unitario non ha che centocinquanta anni, il nome e l'idea o anzi le idee di Italia sono molto più antichi. Questo libro inconsueto vuole raccontare la storia di quel complesso di idee: l'Italia prima dell'Italia. Dagli Italòi - abitanti della Calabria meridionale secondo Antioco di Siracusa (V secolo a.C.) - all'Italia descritta da Plinio e celebrata da Virgilio in lode di Augusto, all'Italia unificata nella lingua dall'audacia di Dante, il libro ricostruisce il tessuto, insieme variegato e compatto, di un paese che riesce ad alimentare, anche se privo di uno stato, la grandezza non solo culturale e artistica del Rinascimento e delle età successive: una nella lingua e nella letteratura, l'Italia offre alla civiltà occidentale un comune orizzonte diplomatico, umanistico, religioso, che garantisce dignità alla dimensione municipale della piccola patria e insieme a quella, più grande, della cultura internazionale.DISPONIBILE IN 6/7 GIORNI
€ 35,00
Francesco Bruni insegna Storia della lingua italiana nell'Università di Venezia. Per il Mulino ha pubblicato "Boccaccio. L'invenzione della letteratura mezzana" (1990), "La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini" (2003) e "L'italiano letterario nella storia" (2007) nella serie da lui curata "Storia della lingua italiana".Se l'Italia come stato unitario non ha che centocinquanta anni, il nome e l'idea o anzi le idee di Italia sono molto più antichi. Questo libro inconsueto vuole raccontare la storia di quel complesso di idee: l'Italia prima dell'Italia. Dagli Italòi - abitanti della Calabria meridionale secondo ... Antioco di Siracusa (V secolo a.C.) - all'Italia descritta da Plinio e celebrata da Virgilio in lode di Augusto, all'Italia unificata nella lingua dall'audacia di Dante, il libro ricostruisce il tessuto, insieme variegato e compatto, di un paese che riesce ad alimentare, anche se privo di uno stato, la grandezza non solo culturale e artistica del Rinascimento e delle età successive: una nella lingua e nella letteratura, l'Italia offre alla civiltà occidentale un comune orizzonte diplomatico, umanistico, religioso, che garantisce dignità alla dimensione municipale della piccola patria e insieme a quella, più grande, della cultura internazionale.
Francesco Bruni insegna Storia della lingua italiana nell'Università di Venezia. Per il Mulino ha pubblicato "Boccaccio. L'invenzione della letteratura mezzana" (1990), "La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini" (2003) e "L'italiano letterario nella storia" (2007) nella serie da lui curata "Storia della lingua italiana".
Iscrizione Newsletter Libreria Coletti